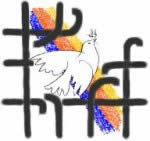I Parlamentari Europei contro la pena di morte
Questo incontro avviene nell’imminenza del Giubileo delle Carceri, una coincidenza non voluto, ma non per questo senza significato, tanto più che Giovanni Paolo II, nel messaggio inviato agli Stati e ai Governi, vuole proporre “uno stimolo per la comunità a rivedere la giustizia umana sul metro della giustizia di Dio”. Si tratta senza dubbio di una proposta alta che giustamente non poteva non scuotere le coscienze. E se il messaggio papale investe l’intero sistema carcerario con l’aggiunta della richiesta di un gesto di clemenza, tuttavia la tensione morale che traversa quelle nove pagine di testo si riversa tutt’intera nel tema del nostro incontro. Per parte mia cercherò, con brevi cenni, di inserirmi in questo filone che potremmo dire religioso, lasciando ad altri, ben più esperti di me, le riflessioni di ordine etico, giuridico e sociale.
Com’è noto fin le prime pagine della Scrittura si aprono con il divieto di uccidere. Dio, con solennità, di fronte all’assassino Caino, disse: “Chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte”. Ma non sempre nelle pagine della Bibbia questo principio sia stato sempre chiaro alle coscienze. La storia di questo tema è stata non poco travagliata. Non è questa la sede per delinearne il tragitto, tuttavia credo si debba dire che la coscienza cristiana odierna è cresciuta in profondità in questo ambito comprendendo le antiche parole della Scrittura “Non uccidere” nel loro senso più autentico dell’intero contesto biblico. Come c’è nella storia cristiana quel che viene tecnicamente chiamato lo sviluppo del dogma, così esiste, direi a maggior ragione, un’approfondimento della coscienza relativamente ad alcuni temi. Non comprendere questom porta ad una lettura fondamentalista della Scrittura, ma soprattutto dimentica che il cristianesimo è una rivelazione storica e, come tale, non si affida ad asserti teorici ma ad una progressiva rivelazione divina. Tutto ciò non nega evidentemente che già nella Scrittura ci siano elementi che paiono essere contraddittori. Tuttavia nell’intero itinerario della Bibbia vi è come lo snodarsi di un filo rosso che manda segnali molto chiari e precisi. Si tratta di dichiarazioni sistematiche che vengono progressivamente ribadite e che fanno parte di questo processo evolutivo della Rivelazione.
Vi è una prima e grande dichiarazione relativamente all’uomo. E’ quella che potremo chiamare l’antropologia biblica. L’uomo, nella Scrittura, è sempre considerato come un essere che ha in sé una radice trascendente. E’ una delle grandi verità bibliche che pur nelle contraddizioni viene sempre sostenuta. L’uomo non può mai essere chiuso nell’orizzonte del finito. E’ la grande affermazione dell’uomo fatto ad immagine di Dio. Nel libro di Giobbe si scrive che Dio e solo Lui, ha in mano l’anima di ogni vivente, e solo Dio perciò può decidere quando troncarlo. Questa dimensione teologica dell’uomo non viene mai cancellata. Nel libro della sapienza si legge: “Tu Signore risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, o Signore amante della vita”. E subito dopo fa un esempio: Dio avrebbe potuto eliminare gli egiziani in maniera radicale e totale, i nemici per eccellenza di Israele, ed invece li ha puniti solo parzialmente perché doveva insegnare ai suoi figli ad amare anche i nemici. Insomma l’etica veterotestamentaria ha un riferimento sempre trascendente.
L’episodio basilare a considerare si trova nel libro della Genesi (4, 9-16). Il Signore denuncia quello che Caino ha fatto: “si sente il sangue di tuo fratello chiedermi dal suolo” (v. 10). Il sangue versato di Abele è un attentato ai diritti di Dio che è l’unico Signore della vita. E Dio non scusa l’azione omicida di Caino, dominato per la malvagità ed è bandito dalla terra, si trasforma in un fuggiasco. La terra per lui è maledizione. Dovrà vagare per il mondo, incapace di sopportare il suo crimine. Caino stesso si dà una sentenza di morte quando dice: “chiunque mi trovi mi ammazzerà” (v. 14). Il primo assassino applica a sé stesso la legge del taglione, non come qualcosa desiderata, bensì come qualcosa di inevitabile ed evidente. Caino deve morire perché ha ammazzato.
Ma Dio non lo maledice. Al contrario, vuole che contini in vita, non desidera che il suo sangue sia “legittimamente” versato: guai a chi tocca Caino! La volontà divina di salvare Caino rimane sottolineata con un segno che indica difesa e protezione. La giustizia del Signore non si attua con la morte di Caino. C’è qui una reazione alla legge del taglione che imponeva di ammazzare Caino. Se Caino non è stato capace di conservare la vita di Abele, il fratello piccolo, il Signore, invece, sarà guardiano della vita del primo nato nella terra. Il Signore ha misericordia della vita di Caino secondo quel principio che unifica le prime pagine del testo biblico: il Dio creatore è il Signore della vita. Egli aveva proibito all’uomo di mangiare del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male (Gn 2, 17), ma quando l’uomo lo mangiò Dio non lo fece morire, andando così contro quello che egli stesso aveva decretato. Del resto Eva attribuisce la nascita di Caino alla forza creatrice di Dio. Ed è qui che risiede la ragione ultima della salvezza del perché Caino non deve morire: ogni uomo è procreato “col favore del Signore” (v. 1). Contro il principio della proporzione della pena (il male si paga con male, il sangue si aggiusta con più sangue) si stabilisce il principio della sproporzione della colpa (l’odio non può ripararsi con più odio). Contro una prassi di morte (ad una morte gli corrisponde un’altra morte) si instaura una prassi di vita, basata e praticata da Dio stesso.
Certamente, nella storia sociale e religiosa dell’umanità la vendetta di sangue sarà un “ritornello” costante, giustificato con molte e diverse ragioni. La stessa Bibbia testimonia la validità che ha per molti la legge del taglione come norma inattaccabile di giustizia, come retribuzione di stretta proporzionalità. Nella Bibbia, la legge del taglione è formulata nell’episodio dell’alleanza di Dio con Noé: “Chi versa sangue di uomo, per un altro uomo sarà il suo sangue versato”(Gn 9, 6). E’ evidente la considerazione su cui si basava, ossia che l’uomo è creato ad immagine di Dio, e che la sua vita è sacra perché riflesso di Dio stesso.
Bisognerà aspettare il Vangelo perché la vendetta venga esautorata e la legge del taglione eliminata grazie alla proclamazione di una giustizia maggiore. In una parola, con Gesù si recupera quello che il Creatore volle fin dall’inizio e che la malizia degli uomini aveva rovinato. Gesù dice no alla legge del taglione, ossia alla vendetta soggiacente nel principio occhio per occhio, dente per dente, qualificato come dottrina degli antichi, che andava superata. Con il Vangelo si pone la base definitiva del non alla pena di morte. E si collega ad un filo rosso che traversa tutta la Scrittura, sin dall’inizio, quando Caino viene preservato dalla morte, e Noé dal diluvio, e Ismaele nutrito nel deserto, e Giacobbe liberato dall’ira di Esaú. Anche Giuseppe, il figlio di Giacobbe, si riconcilierà con i suoi fratelli che avevano cercato di ucciderlo. E poi Davide, perseguito da Saul, si rifiuta di giustiziarlo con le proprie mani. Anche Eliseo, dopo avere accecato i soldati aramei che volevano ammazzarlo e di condurlo fino alla città di Samaria, non permette che il re di Israele li stermini; al contrario, ordina che siano rifocillati e rimandati in libertà. Dopo questo gesto di clemenza gli aramei smisero di invadere la terra dell’Israele (2Re 6, 23). L’atteggiamento di Eliseo portò frutto per tutto il paese.
Gesù propone un nuovo principio, del tutto diverso dalla proporzionalità: la cultura dell’amore come forma giusta di relazione tra le persone. Questo principio trova le sue radici nella giustizia di Dio. Dio è giusto non perché condanna ma perché difende e salva il debole e l’afflitto, l’orfano e la vedova, lo straniero e chi è senza aiuto. Il culmine della giustizia di Dio non è la pena inappellabile ma il perdono concesso per chi è compassionevole e benigno. Questo filo conduttore che attraversa tutto l’Antico Testamento, collega i profeti ed i salmi con Gesù di Nazaret. Nel ministero del profeta galileo si apre una nuova giustizia che si esprime nel perdono, la riconciliazione ed una nuova comunione tra le persone. La frase ama il tuo prossimo come te stesso, che Gesù estrae del libro del Levítico (19, 18), si trasforma nel secondo comandamento della nuova Legge e suppone un non deciso alla vendetta. In realtà, nella prima parte del versetto del Levítico si dice: non ti vendicherai né serberai rancore ai figli del tuo paese. La vendetta è l’antitesi dell’amore al prossimo e, pertanto, la legge del taglione, basata nella retribuzione stretta, si scontra con il comandamento dell’amore. Ed è significativa la risposta di Gesù a Pietro che gli chiede se deve perdonare sette volte. Gesù risponde capovolgendo l’affermazione orgogliosa e violenta di Lámec (Gn 4, 24), non solo sette volte ma settanta volte sette.
In questa luce si può leggere la singolare interpretazione di Borges sull’episodio di Caino e Abele. Borges, immaginando che i due fratelli ad un certo punti si ritrovino, fa dire ad Abele: “Sei stato tu che hai colpito me, o io che ho colpito te?” In quel momento la dimenticanza per amore fa rinascere.
C’è una prima riflessione da fare per chiarire l’equivoco in cui cadono coloro che sostengono essere presente nella Bibbia la pena di morte. Direi anzitutto che nella Bibbia ci sono alcune delle contraddizioni che accompagnano la coscienza umana ma che man mano cresce la storia dell’ascolto di Dio cresce e si purifica per così dire la stessa dottrina. Se per un verso c’è la condanna di chi uccide Caino, per altro verso la presenza della pena di morte sembra un fatto scontato. Ad esempio il comandamento “non uccidere” non è posto in modo così radicale da escludere qualsiasi uccisione. Il conteso porta a dire che si tratta solo dell’esclusione dell’assassinio. Questo anche per la povertà del vocabolario dell’ebraico biblico, appena 6750 parole. Scorrendo le pagine bibliche ci imbattiamo più volte nella presenza della pena di morte. In Israele la pena di morte, seppure molto ridimensionata rispetto agli altri codici orientali, era inflitta per i reati contro la vita, contro la religione e contro la famiglia. Va anche notato che era importante il coinvolgimento di tutti all’esecuzione. Non vi era solo l’esecutore, ma tutti dovevano essere partecipi di quella morte. E in questo c’è forse un aspetto che alla fine può aiutare a maturare lo scandalo per la condanna a morte. Si potrebbe inserire qui il testo famoso di Camus quando riferisce del padre che, dopo aver partecipato ad una esecuzione, sente una profonda lacerazione interiore che non può essere facilmente ricomposta.
LA BIBBIA E LA PENA DI MORTE
A proposito della pena di morte possono stabilirsi fondamenti giuridici, di ambito sociopolitico, o fondamenti filosofici, vincolati con l’etica, ma, indubbiamente è nel mondo religioso dove i vincoli risultano più significativi: i motivi religiosi sono fondamentali per dire non alla pena di morte. Lo sono perché molti ricorrono precisamente alla Bibbia o a principi religiosi per cercare la giustificazione della pena capitale. Un caso emblematico sono gli Stati Uniti di America dove molti governatori e giudici che l’applicano si dichiarano cristiani ed alcuni incluso fanno campagna a beneficio della pena di morte. Pertanto, il testo biblico deve parlare per se stesso affinché rimanga verificato il nostro punto di partenza: la pena di morte contribuisce a mantenere lo spargimento di sangue, e, in conseguenza, non concorda al bene caro per Dio né al bene che qualunque uomo può desiderare.
Il comandamento divino di “non ammazzare”
La pratica dei dieci comandamenti o decalogo è la risposta di Israele al Dio dell’alleanza. Quando Israele arriva dal Sinaí, il Signore lo si manifesta spettacolarmente (Ex 19, 16), e quando si produrce questa manifestazione (Ex 20, 18) il paese riceve di lui i comandamenti (vedere ugualmente Dt 5, 2-5). Perciò i comandamenti non sono qualcosa di estrinseco o imposti da fuori ma plasmano le esigenze dell’alleanza. Esprimono la volontà di Dio, formulandola e comunicandola affinché sia accolta, vissuta e praticata. I comandamenti si basano su Dio stesso e per questa ragione possiedono un carattere assoluto. Sono pilastri, principi. In concreto, il “non ammazzare” traduce, con una formula proibitiva, il carattere sacro della vita e di qualunque vita. Bobbio afferma che il rispetto alla vita è un principio indiscutibile che proviene dal comandamento “non ammazzare.”
Chi ammazza si crede con potestà per disporre della vita dell’altro. Ammazzare implica sempre il trionfo della violenza, benché sia sotto l’apparenza dal diritto. Per questo, di entrata ammazzare ripugna, ma, invece, sorgono in molti non pochi dubbi sulla convenienza di farlo in certe occasioni e sotto certe condizioni. Ad un’atteggiamento temporeggiatrice verso la pena di morte, applicata con cautela ed in certi casi estremi, si contrappongono i cinque enunciati seguenti che scompaginano di modo assoluto le implicazioni del quinto comandamento: a) ammazzare un uomo è ammazzare l’immagine di Dio (Gn 1, 27); b) ammazzare un uomo è usurpare quello che è prerogativa di Dio, il giudizio finale e definitivo su qualcuno, poiché la morte è sempre irreversibile; c) la morte per esecuzione implica il rischio di errore, poiché può togliersi la vita ad un innocente oppure l’assassino può avere le sue capacità mentale diminuite o transtornate; d) ammazzare è utilizzare la massima violenza contro qualcuno, ma dobbiamo domandarci fino a che punto è legittimo usare la forza; e) ammazzare è rovesciare il senso della vita come tale che non è mai la morte bensì la stessa vita: Dio è Dio di vita. Questa è la sua volontà.
Di quale forma il comportamento di Dio, come lo troviamo nella Bibbia, avalla la forza del “non ammazzare?” La prima risposta si trova in lui stesso che è fonte di giustizia e di perdono, che è datore di vita. In virtù di questo principio, la cosa più grave, come la morte/assassinio del fratello di sangue (Caino che ammazza Abele) (Gn 4,8), e la cosa più insignificante (irritarsi con l’altro) (Mt 5, 22) meritano una valutazione simile: c’è un non assoluto alla morte in tutte le sue forme.
Dio è Signore della vita
1.2. È possibile non ammazzare?
Approfondiamo nel quinto comandamento. La proibizione di ammazzare un altro essere umano è iscritta nel cuore di ognuno. Se c’è qualcosa di personale, è la vita e la nostra condizione di esseri vivi. La persona umana sussiste mentre c’è vita, e per questo motivo il cristianesimo che proclama la sua fede nell’altra vita, concede in questo alla persona un gran valore, una totale dignità. Non è legittimo, dunque, disporre della vita dell’altro. È una conclusione che si impone per lei stessa, poiché ha forza di premessa: il rispetto alla vita dell’altro è un dato previo, una delle prime evidenze che esistono nella coscienza umana e che le leggi sanzionano con ogni rigore. Nonostante, il rispetto dovuto alla vita dell’altro è stato calpestato moltissimi volte nella storia degli uomini. La trasgressione della vita ha accompagnato molti momenti della relazione tra gli esseri umani, i quali, in non poche occasioni, hanno agito come esseri realmente inumani, ammazzando per il gusto di ammazzare, in maniera accanita e senza scrupoli. Ammazzare si è convertito in un commercio ed un divertimento; ad alcuni pagano loro per farlo, altri lo fanno senza nessuna coscienza, come il bambino-soldato, programmati e violentati nella cosa più intima del suo essere. Ci sono tante ragioni per ammazzare, se rivuole ammazzare! Ma la ragione principale è l’odio ed il disprezzo. Nessuno amazza se, in fondo, non odia o umilia o esclude o degrada la sua vittima. Di tutti è conosciuto che, davanti all’opinione pubblica, i condannati a morte sono presentati spesso come mostri di malvagità, animali assassini, individui che non meritano il nome di persone. Con questo, è facile mettersi di accordo che devono essere eseguiti, come si darebbe morte ad una tigre furiosa o ad uno squalo assetato di sangue.
L’odio, dunque, è il denominatore comune della relazione che si stabilisce tra chi ammazza o fa ammazzare e la persona che perde la vita. L’odio si trova nella radice di qualunque omicidio o esecuzione. Chi ama, non ammazza. Chi odia, non può smettere di ammazzare se questo odio diventa insopportabile, onnipresente, senza uscite. Pertanto, non è sufficiente ricordare il quinto comandamento del decalogo (non ammazzerai); dobbiamo domandarci come può osservarsi questo comandamento. Gesù si porsi questa stessa questione nel Sermone della Montagna e gli dedica la prima delle chiamate sei antitesi (vedere Mt 5, 21-26). Il punto di partenza di questo testo evangelico è il seguente precetto: la Legge promulgata per Dio nel Sinaí proibisce che qualcuno disponga della vita dell’altro, e chi trasgredisca la Legge dovrà andare a giudizio e sarà condannato per il tribunale (v. 21). Naturalmente non viene specificato in che cosa consisterà la pena: in realtà, il protagonista del Nuovo Testamento è un uomo, chiamato Gesù di Nazaret, condannato a morte e giustiziato! Il riferimento sembra essere espressamente ambiguo. Ma a Gesù non gli interessa quell convinto di omicidio e le sue conseguenze penali; gli preoccupano le premesse che l’istigano e lo provocano. Per lui deve rimanere in evidenza l’importanza del conflitto, del confronto, dell’odio, della violenza convertita in una spirale che porta, fatalmente, all’eliminazione fisica dell’altro. Gesù lo concentra tutto sulla violenza verbale e cita tre casi di progressione ascendente: irritarsi, insultare, maledire. Di entrata, sembra che esageri: è tanto decisivo arrabbiarsi con qualcuno? Non è moneta corrente e giornaliera discutersi o arrabbiarsi con un’altra persona? Senza dubbi! Perché, agli occhi di Gesù la facilità con la quale c’irritiamo contro qualcuno non diminuisce l’importanza del fatto ma l’aggrava. Irritarsi contro un’altra persona è tanto grave come ammazzarla: notiamo che in entrambi i casi si dice che il trasgressore sarà condannato per il tribunale (paragoniamo Mt 5, 21 e 5, 22). E benché Gesù non capisca che si tratti di una condanna alla pena capitale, insiste in che la gravità è la stessa in un caso e nell’altro. Nella seconda ipotesi, cioè, che qualcuno insulti ad un altro che lo disonori con una parola offensiva, questo tale diventerà meritevole di un verdetto di condanna emesso per il Sinedrio, l’istituzione più alta del paese ebreo, quello che ora chiameremmo la corte suprema. La sproporzione tra colpa e pena, accentuata per Gesù non senza una certa dose di esagerazione ed ironia, arriva al punto culminante nella terza ipotesi: quello della maledizione dell’altro. Se la violenza verbale arriva fino al punto di maledirlo, cioè, di attrarre sull’altro il peso della maledizione divina, di considerarlo un ribelle contro Dio, allora la maledizione girerà contro chi la proferisce, e questo tale diventerà meritevole della condanna eterna. Quello che aveva chiesto per l’altro, maledicendolo, ora ricade su lui stesso: Dio condanna al violento che maledice e prende in vano il suo nome, dandogli quello che egli, nella sua violenza, chiedeva per l’altro.
Il vangelo è diretto e concreto: qualunque forma di odio è inammissibile, benché non arrivi all’aggressione fisica (solo verbale) e benché sia incipiente e comune (quante volte alla settimana non ci arrabbiamo contro qualcuno!). La violenza contro l’altro che si traduce nell’omicidio, è un’esplosione di odio che deve essere evitata dal primo momento. Una bomba non esplode se non si infiamma l’animo. Un bosco non arde se non salta una scintilla. Di modo simile, l’omicidio non arriva a consumarsi se l’odio ed il confronto non si accendono nel cuore degli uomini. Non ammazzare è possibile se prima si è ammazzato la radice dell’omicidio, se il sentimento di irritazione o le parole di insulto o la maledizione non germogliano del cuore, il posto di dove escono precisamente gli assassini (vedere Mc 7, 21). Se l’odio non cresce nel cuore dell’uomo, se l’intenzione malvagia di attacco e violenza rimane eliminata dentro lui, non ci sarà volontà né desiderio di eliminare nessuno. La maniera di soffocare in noi qualunque inizio di omicidio è sostituendo il confronto per il perdono. Nell’antitesi del Sermone della Montagna che stiamo commentando (vedere ora Mt 5, 23-24) Gesù espone il caso di chi, nel momento di compiere i suoi doveri religiosi e presentare l’offerta davanti all’altare, si rende conto che è affrontato con suo fratello, o, per meglio dire, si ricorda che l’altro -magari senza nessuna colpa da parte sua – è affrontato con lui. Per Gesù, la situazione non presenta il minore dubbio: l’offerta a Dio può sperare. Prima, quelli che erano affrontati devono perdonarsi e riconciliarsi: vai in primo luogo a riconciliarti con tuo fratello, dice il vangelo (v. 24). L’antitesi dell’omicidio è il perdono. Mentre l’omicidio era la conseguenza inevitabile dell’odio e della violenza, la riconciliazione è il risultato del perdono offerto e della pace ritrovata. Dobbiamo scegliere tra un mondo che perdona e lascia vivere ed un mondo che odia e porta alla morte.
La legge del taglione ed il vangelo
La chiamata legge del taglione che si formula abitualmente con l’espressione occhio per occhio, dente per dente è anteriore alla stessa Bibbia. Appare già nel Codice di Hammurabi (secolo XVIII A.C.) e riappare posteriormente in altre compilazione legislative dell’oriente antico, tra le quali si include la legislazione israelitica (ver Ex 21, 23-25; Lv 24, 18-20; Dt 19, 15-21; 25, 1-12).
2.1 la pena di morte nell’Antico Testamento
In base a queste considerazioni elaborate a partire dagli undici primi capitoli del libro del Genesi che sono il racconto primordiale o delle origini, possiamo situare meglio un dato che percorre tutto l’Antico Testamento: la validità legale della pena di morte applicata in virtù della legge del taglione. Si è detto e ripetuto che questa legge, nella misura in cui stabilisce una pena proporzionata al crimine o delitto, rappresenta un avanzamento notevole in relazione con la vendetta di sangue illimitato. Così, la normativa riferita alle colpe sanzionate con la pena di morte nel chiamato codice dell’Alleanza (Ex 20, 22 – 23, 19) incomincia con questa prescrizione: Quello che ferisca mortalmente un uomo, morrà (Ex 21, 12). Nonostante, questa prescrizione non si applica meccanicamente ed assolutamente. Solo si può parlare di omicidio quando ci sono premeditazione e piena intenzionalità, cioè, quando l’omicidio è volontario. Nel caso che non lo sia, quello che commette l’omicidio può ospitarsi in posti sacri (altari o santuari) o posti protetti (città di rifugio) e così salvare la vita: Dio gli garantisce la sopravvivenza come nel caso di Caino. Per questo l’omicidio di un ladro nell’oscurità della piena notte (Ex 22, 1) o la morte di qualcuno da parte di un animale che attacca senza avvisare (Ex 21, 28) non sono penalizzati con la morte dell’omicida o del proprietario dell’animale, rispettivamente. La volontarietà è un criterio necessario per applicare la legge del taglione ai crimini di sangue. Se questa volontarietà piena non può provarsi, neanche può applicarsi la pena di morte. Invece, merita la morte chi ammazza a tradimento, portato per l’odio contro l’altro (Ex 21, 14), l’israelita che offre sacrifici ai dei (Ex 22, 19) e rinnega così il suo Dio, e lo sposato che mantiene relazioni sessuali con una sposata (Lv 20, 10). Si tratta dei tre peccati maggiori (omicidio, idolatria, adulterio) che ricevono la pena massima nell’Antico Testamento. Ad ogni modo, potremmo domandarci se in questi tre casi la massima pena, la pena di morte, si proporre come soluzione proporzionale oppure semplicemente, indica ed esprime la massima gravità di queste tre mancanze. Si tratta di tre attentati, rispettivamente, contro il diritto umano alla vita, il diritto di Dio ad essere riconosciuto come tale ed il diritto di un sposato a non essere violentato nella relazione umana più sacra, la relazione matrimoniale. La pena di morte segnala quelle azioni come azioni di morte e che portano alla morte, poiché si allontanano dal progetto di Dio che è un progetto di vita. In questa stessa linea, ed oltre una proporzionalità stretta, si decreta pena di morte a proposito del sacrificio di un figlio ad una divinità (Lv 20, 2), le pratiche di magia o stregoneria (Ex 22, 17), il sequestro e vendita di un altro israelita come schiavo (Ex 21, 16) e la violenza esercitata contro i propri genitori, maledicendoli o bastonandoli(Ex 20, 12; 21, 15; Lv 20, 9).
Difficilmente, dunque, può presentarsi l’Antico Testamento come esempio di applicazione stretta del principio di proporzionalità, base della legge del taglione. In altre parole, la Bibbia integra la legge del taglione, anteriore nel tempo, ma sottolinea il principio soggiacente a questa legge, cioè, il principio di responsabilità. In secondo posto, sembra che nella Bibbia la pena di morte sia indizio della gravità della colpa più che una conseguenza, strettamente paritaria, della colpa commessa: l’aggressione ai propri genitori è un chiaro esempio. Pertanto, possiamo salvaguardare la gravità di un’azione delittuosa o criminale senza dovere applicare la legge del taglione e ricorrere alla pena di morte, la quale, come si apprezza in alcuni dei casi citati anteriormente, non si proporse sempre in termini di proporzionalità o retribuzione ineludibile.
2.2. Gesù dice non alla vendetta
Vivere oltre l’odio
A nome dell’intimidazione, cioè, dell’applicazione della pena di morte come esempio disuasorio, molti pensano che può darsi certificato di cittadinanza acquisita alla pena capitale. Ma, non sono solamente le statistiche quelle che mostrano che non c’è relazione tra l’aumento delle sentenze di morte e la diminuzione della criminalità: l’applicazione della pena di morte non contribuisce alla riduzione degli omicidi. La questione ad esporre concerne al valore e gli effetti di una cultura della giustizia violenta. Questa cultura si basa nei sentimenti di vendetta che mirano qui e là nella società e che, in definitiva, risultano legittimati quando il diritto penale di un paese include la possibilità della pena di morte. Cioè, quelli che difendono il principio della prevenzione generale (la pena di morte come punizione esemplare) devono domandarsi fino a che punto un’esecuzione capitale non alimenta di facto la cultura della violenza istituzionalizzata e, pertanto, fomenta l’odio. La vita umana sulla terra, deve sostentarsi sull’odio e la vendetta distruttori oppure su quello che costruisce, cioè, sull’amore e la povertà? Che cosa guadagna l’umanità eseguendo un assassino? A volte si stimolano sentimenti di vendetta, come se lo spargimento di sangue dovesse calmare un’inquietudine, come se dovesse mettere un’altra volta le cose nel suo posto. Si tratta di un’impressione erronea. Togliere la vita a qualcuno, né che sia il più grande degli assassini, è togliere vita all’umanità nel suo insieme. Per questo Gesù si trasforma in punto di riferimento perché egli è un appassionato della vita che dice di sé stesso: Io sono venuto affinché le pecore abbiano vita e l’abbiano in abbondanza (Jn 10, 10).
3.1. Gesù come esempio
Gesù non si pronuncia in maniera esplicita contro la pena di morte nella cornice dell’ordinazione giuridica del suo tempo. Si manifesta, invece, e con forza, contro una punizione divina che comportasse l’eliminazione fisica di qualcuno. Una volta ha incominciato la salita a Gerusalemme, Gesù fa strada accompagnato per i discepoli. Alcuni messaggeri lo precedono con la missione di preparare il suo arrivo. Entrano in un paese di samaritano e questi si rifiutano di accoglierlo: il pregiudizio etico e religioso, la vecchia inimicizia risorge. Immediatamente, due buoni ebrei, i fratelli zebedei, Giacomo e Giovanni, discepoli di Gesù, entrano nella spirale dell’odio e propongono una punizione esemplare che Dio stesso avallerebbe. È intollerabile, il rifiuto del Messia che Dio invia! La vendetta domina quei due uomini che reclamano la morte dei samaritani: vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consuma? (Lc 9, 54). Ma quell camino di Gesù verso Gerusalemme che è di passione e di debolezza, non può incominciare con un atto di arroganza e di forza prepotente. Sarebbe un controsenso clamoroso: Gesù non è il profeta trionfante che distruggerebbe i suoi nemici e mostrerebbe così, in maniera esemplare, il suo potere. Nella sua strada non sta la morte di nessuno, eccetto la sua: l’esecuzione capitale di Gesù si convertirà, paradossalmente, in fonte di vita e di speranza per l’umanità intera. Con la sua sentenza a morte, realizzata mediante una cruenta crocifissione, Gesù condanna tutte le sentenze di morte della storia. Lui carica su sé stesso il peccato del mondo, l’odio e l’ingiustizia, poiché li soffre nella sua carne, e nega loro così ogni tipo di validità. Per questo, davanti alla petizione di Giacomo e Giovanni, reagisce energicamente e sgrida i due discepoli. La morte del nemico non è una strada cara per Dio. Il cielo non si deve aprire affinché scenda un fuoco mortale che stermini gli uomini; al contrario, si è aperto affinché l’umanità riceva il perdono e la pace che spera e necessita.
In maniera simile, l’ultima scena nella quale troviamo insieme Gesù ed i suoi discepoli, giustamente quando incomincia la passione, nell’orto di Getsemaní, è un momento di violenza possibile, ma paralizzata ed evitata. Anche qui, nell’istante della detenzione tutti quelli che Gesù gli fanno una proposta: feriamo a spada? (Lc 22, 49). Giuda è arrivato con un gruppo di gente armata e ha baciato, tradendolo, il Maestro. Il bacio di Getsemaní è un’aggressione, un gesto di odio e non di amore, un segno di rifiuto e di morte, sotto l’apparenza dell’amicizia e dell’affetto. Con questo bacio i guardiani, armati, procederanno a fermare Gesù. La replica sembra chiara: respingere l’aggressione, rispondere all’odio con più odio. Ma Gesù vuole preservare i suoi discepoli dal male: il male deve essere vinto col bene. Dopo che uno che l’accompagnano ferisce con la spada ad un uomo del gruppo che è venuto per fermarlo, Gesù cura questo uomo che aveva perso l’orecchio destro. In un momento, la violenza rimane sostituita per la compassione ed i discepoli imparano una lezione fondamentale: è necessario vivere oltre l’odio, fino a quando la violenza sembra essere l’unica uscita.
L’esclusione dell’odio arriva al suo punto culminante nel momento della crocifissione. Lì, nel Gólgota, assistiamo alla messa in scena della condanna a morte di un innocente, eseguita senza nessuna considerazione. Crocifisso tra due criminali, Gesù si rivolge a Dio, il Padre, e riferendosi ai boia e tutti i responsabili di quell’ingiustizia, dice: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno (Lc 23, 34). È un discorso breve che esprime i sentimenti che c’è nel cuore del quale la pronuncia: sentimenti di comprensione e di benedizione per quelli che l’hanno portato alla morte. È qui come una purificazione dell’amarezza per quello che Gesù ha passato e passa. Gesù soffre il supplizio della croce senza permettere che l’odio, in nessuna delle sue forme, arrivi ad entrare nel suo cuore. C’è una pace che sorge da un cuore senza odio né vendetta. È una pace offerta a tutti: a chi ha ammazzato ed a queli che condannano a morte, a quelli che sono vittime della violenza ed a quelli che chiedono più violenza. C’è nel discorso di Gesù nel Gólgota un investimento essenziale: i nemici, i responsabili della sua morte, non sono trattati come nemici, né di Dio né degli uomini. Qualcuno a chi Dio stesso perdona, non meriterà il nostro perdono?
Nel Gólgota arriviamo alla domanda essenziale: Chi è un condannato a morte? La risposta pare chiara: un nemico di tutta la società. Ma Gesù afferma: Amate i vostri nemici, fate bene a quelli che vi odiano (Lc 6, 27). Cioè, trattate i nemici come trattereste gli amici, non li malediciate, pregate per essi, non scarichiate su essi la vostra violenza, non li condanniate. Benché abbiano calpestato, magari, le leggi più sacre, non facciate loro oggetto del vostro odio, né che sia a nome di un ordine sociale che dovrebbe rispondere e difendersi con una legislazione inappellabile. Gesù non propone il rifiuto del nemico; invita a considerarlo un essere umano, propone comprenderlo spesso nella sua umanità scardinata, vuole trattarlo come prossimo. Le parole di Gesù nella croce a proposito dei nemici ci fanno guardare ogni uomo, fino al condannato a morte, con un sguardo di povertà.
Questo è lo sguardo che Gesù, un condannato a morte, rivolge ad un altro condannato a morte, il suo compagno di supplizio. Delle tre croci impalate nel Gólgota, Gesù, l’innocente, occupa quella del mezzo, mentre i due criminali crocifissi con lui si trovano ad entrambi i lati. Si tratta di un’immagine tristemente frequente: nei corridoi della morte aspettano mischiati uomini colpevoli ed uomini innocenti. Uno dei due criminali riprende Gesù e l’ingiuria, pieno di amarezza. È un uomo disperato. L’altro, invece, costruisce una storia di amicizia con Gesù, necessariamente breve ma intensa. Per lui, Gesù non è un Messia che non sa fare da Messia, non lo ridicolizza né lo sottovaluta. Al contrario, Gesù è una persona amica, solidale in una stessa pena, nonostante la sua radicale innocenza, riconoscente senza rancore: questo niente cattivo ha fatto (Lc 23, 41). Più ancora, quell’uomo che riconosce la bontà di Gesù e la sua intimità con Dio, chiede al Messia crocifisso che non l’abbandoni che si ricordi dopo di lui, quando entri nel suo Regno. Il criminale amico di Gesù morrà come egli ed entrerà con lui nel paradiso. La storia di amicizia tra quelli due condannati a morte culminerà presto, dopo l’esecuzione, e durerà per sempre. Per Gesù, quell’uomo non è un criminale che riceve quello che meritano i suoi atti. A Gesù non gli interessa il male che quell’uomo ha fatto anteriormente bensì il bene che cerca ora, l’amicizia che necessita, il futuro nel quale crede. Quello criminale non è un nemico, indegno di ricevere e chiedere misericordia. Cerca la vita e diventa meritevole di lei: il paradiso non può essere negato ad un amico! Gesù raccoglie la speranza di quell’uomo e gli dà il tesoro che desidera. Aprendogli le porte del paradiso, lo perdona, e perdonando glielo apre il camino della vita. Quel criminale vede così non commutata la sua pena di morte per l’ergastolo bensì per la libertà del Regno del Padre. La condanna di morte più clamorosamente ingiusta della storia trova il suo contrappunto in un perdono dato all’amico pentito e riconciliato che passa veloce per la morte ed entra allegro nella vita.
Il condannato a morte, colpevole o a volte innocente, è un povero del Signore, un uomo che, in parole di Sister Helen Prejean, si trasforma nel viso vivo di Gesù Cristo e, pertanto, non può essere considerato un nemico che debba eliminarsi. Al contrario, nel vangelo si menzionano i più piccoli del Regno, gli indifesi e bisognosi di ogni tipo, alcuni dei quali stanno nel carcere (Mt 25, 36). E Gesù, riferendosi a quelli che si avvicinano a quegli imprigionati ed a quelli che si trovano nel corridoio, dice loro: E veniste a vedermi. Dietro ogni prigioniero, dietro ogni condannato a morte è il viso del crocifisso, sdegnato, emarginato tra gli uomini, avuto per un frustato, ferito di Dio e vilipeso a chi hanno imprigionato e condannato, in espressioni del Quarto Cantico del Servo (Is 53, 3.4.8). La passione di Gesù, il Signore, continua nella passione di molti e di molte il cui camino di scherzi, torture ed umiliazione rimane associato al via crucis del venerdì Santo. Depredati della sua umanità, sono come un verme agli occhi di molti, secondo le parole del salmo 22 applicate alla passione di Gesù: invece Io sono verme, non uomo (v. 7). Risuonano, come contrappunto, le parole di un altro salmo, il 72, che spiegano l’itinerario di Gesù, quello che passerà per tutti i posti facendo il bene: Perché libererà il povero supplicante, allo sfortunato ed a chi nessuno protegge; si impietosirà del debole e del povero, salverà la vita dei poveri. La riscatterà dell’oppressione e la violenza, considererà il suo sangue prezioso (vv. 12-14).
3.2. Il perdono è il centro del vangelo
C’è un testo nei libri sapienziali che si riferisce, con gran convinzione, ai mali derivati del rancore, compagno di viaggio dell’ira, la vendetta e l’odio. In maniera lapidaria sentenza: Pensa al tuo fine e smette già di odiare (Se 28, 6). Dello stesso modo che arriva loro la morte e la corruzione a tutti, a tutti deve arrivare il perdono, afferma il testo biblico. L’unico ricordo che vale la pena è il ricordo della povertà di Dio. Ci sono molti altri ricordi che rovinano il cuore e distruggono lo spirito. L’uomo che perdona la vita ad un altro rimane nobilitato davanti a tutti e diventa meritevole del perdono del Signore. In effetti, Dio, il Padre, perdona le colpe a chi è stato capace di perdonare a quelli che l’hanno offeso. Così la manifesta Gesù nel discorso che propone ai suoi discepoli: e perdonaci le nostre offese, come noi perdoniamo a quelli che ci offendono (Mt 6, 12). Questo è il nodo centrale della nostra risposta alla misericordia di Dio. Chi può dire che non ha colpa? Chi può agire al margine dal vangelo della grazia? Chi può condannare senza paura ad essere condannato, in virtù di una legislazione che passa da lontano del vangelo? Davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali e hanno bisogno dello stesso perdono. Ma la ferita interna deve essere guarita. Quello che potendo perdonare, non perdona, e potendo non condannare, condanna, mantiene aperta una ferita che li toglie umanità. Decretare la pena di morte non è solo giudicare di accordo con un codice legale, bensì giudicare col cuore, l’intenzione e la volontà, quello che appartiene solo a Dio. Dice Gesù: non giudichiate, affinché non siate giudicati (Mt 7, 1). Cioè, perdonate e sarete perdonati! La parabola del servo senza compassione (Mt 18, 23-35) espressa chiaramente la differenza di misura. Non c’è punto di paragone tra i diecimila talenti che il re perdona ad un suo subordinato ed i centi denari che questo è incapace di perdonare al suo compagno. Possiamo domandarci se la condanna a morte non è paragonabile ai centi denari non perdonati per un’umanità a chi sono stati perdonati diecimila talenti.
In un’altra parabola, quella del fariseo ed il pubblicano (Lc 18, 9-14), troviamo un’incapacità simile. Un uomo che pratica scrupolosamente la Legge di Moisè che non ruba né fa male il che digiuna e paga la decima al tempio di Gerusalemme, rimane contrapposto ad un altro uomo, carico di colpe gravi, come frodi, furti ed estorsioni. Il paragone tra in primo luogo il, uomo rispettato e rispettabile, ed il secondo, persona senza scrupoli, non ammette replica: l’onorabilità del fariseo non ha niente a che vedere con la brutta fama del pubblicano, pubblica e notoria. Quello diventa meritevole, con ogni diritto, di elogi e considerazioni, mentre il secondo, con ogni diritto anche, si fa male vedere per gli altri. Il pubblicano lo sa, riconosce la sua condizione di uomo debole e colpevole, e per questo si rivolge a Dio chiedendogli misericordia: O Dio! Abbi compassione di me che sono peccatore! (v. 13). È il discorso sincero e giusto di un uomo che ha vissuto nell’ingiustizia e che accorre al Dio del perdono e della pace. È un discorso che tocca il cuore di Dio che non chiede niente e che lo chiede tutto, diretta all’unico che può salvare la sua vita. Per questo è un discorso ascoltato ed accolto, perché il Signore esalta a quelli che si umiliano. Quell’uomo è perdonato, perché non c’è niente che Dio non possa perdonare a quello che si presenta davanti suo senza nascondere niente. L’altro, invece, il fariseo, non riceve il perdono divino. In realtà, neanche lo chiede: è convinto che non ha bisogno di lui. E neanche quello che non si chiede, si riceve. Il suo atteggiamento interno, di gran prepotenza, rimane dissimulato davanti a tutti per un comportamento irreprensibile. Ma in realtà è un atteggiamento di orgoglio che Gesù denuncia mettendo nelle sue labbra qualcosa che lo denuncia: egli non è come questo pubblicano (v. 11). Il fariseo fissa così una distanza insuperabile tra lui ed il pubblicano, e questa distanza si traduce nel disprezzo ed il rifiuto. La sua virtù, reale, non porta al perdono, bensì alla condanna. Invece, la bontà di Dio, la sua misericordia, si concretizzano nel perdono generoso e senza misura, offerto e ricevuto per il pubblicano. L’odio contro l’altro e l’orgoglio di uno stesso inabilitano per il perdono, il centro del vangelo.
Chi condanna è incapace di superare l’odio per l’altro e, eventualmente, l’orgoglio della sua virtù, ma, soprattutto, si sente imprigionato per il suo proprio peccato. L’episodio della donna adultera (Jn 8, 1-11) così lo dimostra. Mentre Gesù insegna alla gente nel recinto del tempio, portano una donna alla quale hanno sorpreso commettendo adulterio. Si tratta di una mancanza molto grave per la quale la Legge di Moisè prevede la pena massima: la lapidazione pubblica fino alla morte (vedere Lv 20, 10). La Legge mosaica applica qui il principio della prevenzione generale che propone una punizione esemplare: estirpa di Israele la malvagità (Dt 22, 22). Come reagirà Gesù davanti ad una mancanza molto grave, paragonabile all’omicidio e a l’idolatria, e per la quale la Legge di Moisè prevede la pena di morte? Come è abituale in lui, Gesù va oltre la Legge, e di qualunque legge, e situa la questione nel concreto della vita. In realtà, se, secondo la Legge, la donna merita la pena di morte, la sentenza non deve essere eseguita da un boia, di accordo con la sentenza di un giudice, bensì per tutte le attestazioni dell’adulterio, convertitosi in accusatori e, pertanto, in giudici e boia: essi sono quelli che devono lapidarla pubblicamente. Ma, chi può giudicare senza essere giudicato? Chi può dire che è libero di peccato e tirare la prima pietra? Prima di togliere la paglia che c’è nell’occhio del prossimo, ognuno deve togliersi la trave del suo proprio occhio. È abituale che, davanti al peccato degli altri, reagiamo condannando. Ma primo dobbiamo cadere nel conto dal nostro proprio peccato. Se ci sappiamo membri di un’umanità che mescola il bene ed il male in maniera inseparabile, allora riconosceremo i nostri errori e non condanneremo nessuno. È la conclusione dell’episodio evangelico. Nessuno condanna alla donna, poiché, incominciando per gli accusatori più vecchi, tutti vanno via. La scena rimane vuota. Lí sta solo la donna a chi ora nessuno condanna, e Gesù che afferma solennemente: neanche Io ti condanno (v. 11). L’unico che non ha peccato e che, pertanto, potrebbe condannare, non lo fa. Al contrario, perdona. Di questa maniera, rimane chiaro quello che Dio vuole dall’inizio. Caino ha assassinato suo fratello, e Dio lo salva della morte. L’adultera, secondo la Legge, meriterebbe la morte e Gesù, con l’autorità di Figlio di Dio, superiore alla Legge, salva quella donna, che ritorna alla vita.
Conclusione: dal “non ammazzare” al “non condannare”
La pena di morte, decretata ed applicata, è una sconfitta della vita e dei diritti fondamentali della persona. È una ferita all’umanità, una conseguenza della cultura dell’odio e della vendetta. L’annuncio di un’esecuzione capitale non è mai una buona notizia, fino nel caso del crimine più orribile. Un’esecuzione non è vangelo, e, pertanto, non è evangelica. Gesù si allontana dalla pena di morte. Nel suo vangelo non sta la violenza incontrollabile e distruttrice che si nasconde dietro una legislazione che include la pena capitale. Che cosa significa fare giustizia? Ammazzare a chi ha ammazzato? Nei suoi primi compassi, la Bibbia si riferisce alla vita di Caino che è preservata; dopo nel Sinaí si proclama il quinto comandamento che difende la vita; finalmente, culmina col vangelo del perdono di Dio, annunciato per Gesù di Nazaret. La legge del taglione entra nella Bibbia in maniera stretta, delimitata. Ma il vangelo la supera col doppio comandamento dell’amore: a Dio ed al prossimo, anche al prossimo che ha commesso un omicidio. Di questa maniera il comandamento di non ammazzare, presente nel decalogo, si orienta verso il comandamento nuovo dell’amore ai nemici, centrale nel Padrenostro ed il Sermone della Montagna. Il vangelo è buona notizia di vita ed è portatore di vita. Come dice Olivier Clément: Nel Cristo resuscitato non desideriamo oramai morire, non desideriamo oramai toglierci la via o toglierla ad altri. (Armand Puig i Tàrrech)