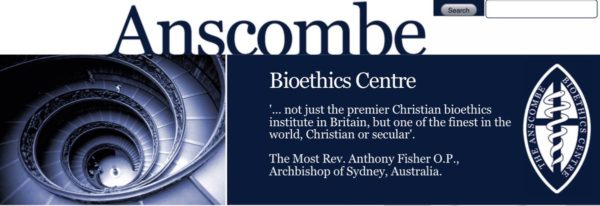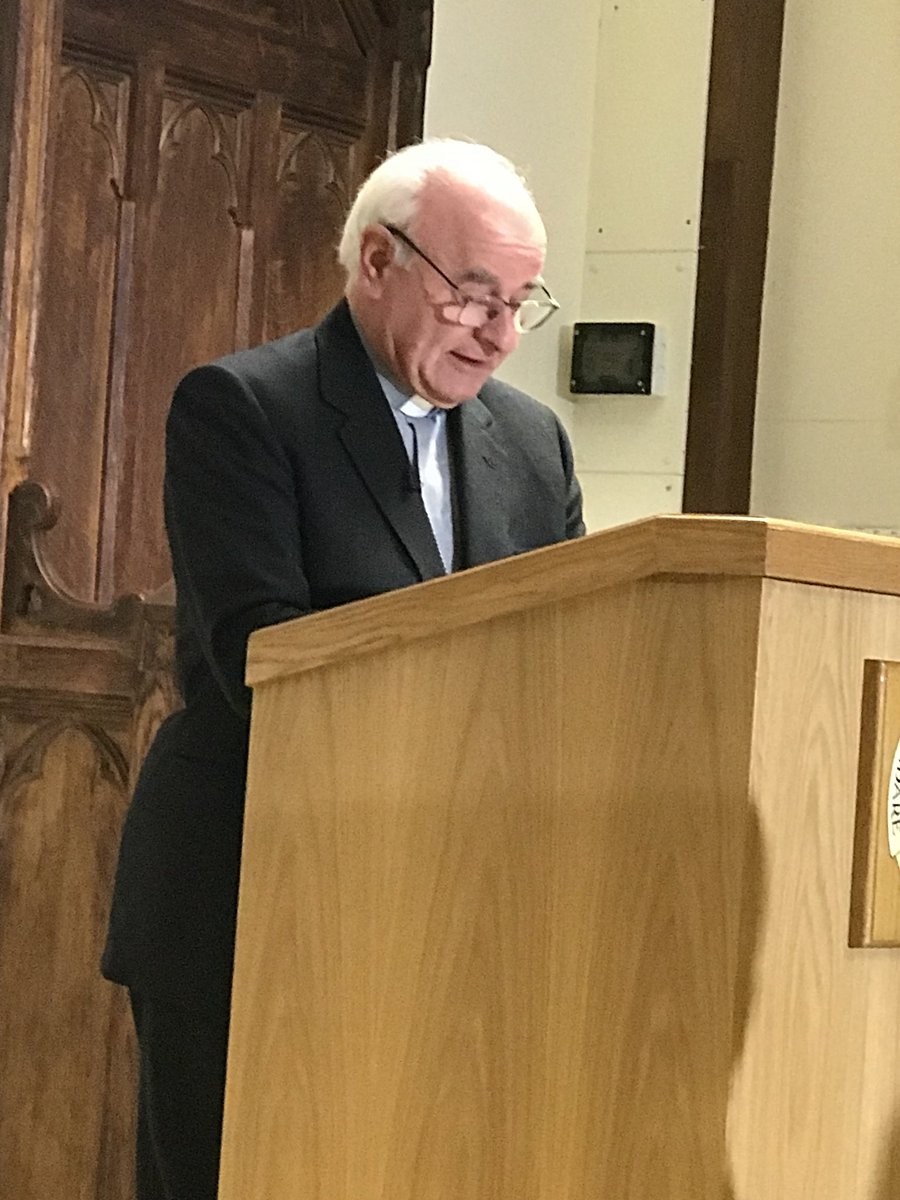Human dignity and bioethics – Dignità umana e bioetica
Oxford Ascombe Center – Las Casas Institute, 12th of february 2018
HUMAN DIGNITY AND BIOETHICS – february 12, 2018
read and download
Desidero anzitutto ringraziarvi per questo invito e per l’attualità del tema che avete scelto di propormi. La questione della dignità umana è infatti molto presente nel dibattito pubblico, sia nell’ambito della bioetica, sia in contesti più vasti che mettono in gioco la convivenza sociale nel suo insieme. Va notato però che, pur essendo da tutti invocata, della dignità si danno interpretazioni molto differenti, anche per sostenere posizioni opposte, come accade ad esempio nel campo dell’eutanasia. E’ importante riflettere assieme per individuare un consenso su un tema particolarmente complesso. Va tenuto presente che la nozione di dignità è presente in diversi documenti che hanno segnato il ’900, reagendo agli orrori della Seconda guerra mondiale e con l’intento di porre argini chiari per impedire il ripetersi di tentativi di violenza, di discriminazione e di annullamento dell’umano. Infatti la dignità viene richiamata nel Preambolo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1948, che recita: “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. E l’articolo 1 ribadisce: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Essa è anche più volte invocata nella Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti dell’uomo dell’UNESCO (2005), in riferimento sia all’uomo (artt. 2-3) sia, in modalità più estensive, all’essere umano (Preambolo, art. 10).
La nozione di dignità rimane tuttavia imprecisa e insufficiente per decidere in situazioni concrete. Risulta difficile, ad esempio, dirimere la tensione che nasce quando dignità e libertà della persona si trovano in concorrenza, anche in relazione alle diverse tradizioni di pensiero: mentre nell’Europa mediterranea si tende a dare priorità alla prima, nel mondo anglosassone prevale piuttosto la seconda. Così anche non sempre si trova un punto di conciliazione soddisfacente quando la dignità confligge con altri diritti o esigenze, come nel caso della libertà di ricerca o le libertà economiche. Nascono quindi molteplici domande sulla dignità: sul suo statuto di riconoscibile oggettività, sulla sua incondizionatezza e sui suoi rapporti con altri diritti fondamentali.
Inoltre è innegabile che negli ultimi anni gli sviluppi delle biotecnologie, della robotica, delle neuroscienze se, da una parte hanno consentito grandi passi avanti nella cura della salute, dall’altra hanno posto problemi inediti riguardo ai rapporti dell’uomo con il proprio corpo fin negli aspetti più profondi della coscienza, della generazione, degli equilibri con altri esseri viventi secondo una effettiva giustizia dei nostri rapporti con l’intero mondo della vita.
In questa mia presentazione vorrei in un primo momento mostrare come la situazione dell’attuale conflitto delle interpretazioni sia l’esito di una molteplicità di linee di pensiero presenti nella storia dell’Occidente. Cercherò di raccogliere questi contributi attorno a tre prospettive principali: quella della tradizione ebraico-cristiana, quella dell’etica di ispirazione kantiana e quella più recente dell’antropologia della (tarda) modernità. In un secondo momento, valorizzando quanto le diverse fanno emergere, vorrei individuare una nozione di dignità per quanto possibile coerente. Senza dimenticare che oggi siamo immersi in un contesto sempre più complesso, che ci espone a semplificazioni e distorsioni della comunicazione, rendendo più difficile la reciproca comprensione.
Principali snodi storici della nozione di dignità
La tradizione ebraico-cristiana.
Pur conoscendo diverse accentuazioni e sfumature nel corso dei secoli e in funzione dei mutevoli contesti culturali, la tradizione ebraico-cristiana ha manifestato una notevole costanza circa gli elementi centrali della nozione di dignità. Come viene ricordato dal Concilio Vaticano II (in particolare GS, 12-22), l’impostazione cristiana su questo tema è fondata sulla testimonianza biblica, ampiamente confermata dalla tradizione patristica, secondo cui l’uomo è creato “a immagine e somiglianza di Dio”. Questo vale per ogni uomo e per ogni donna, in qualunque situazione si trovino. La dignità è un altro nome per indicare la “somiglianza” con Dio. Siamo quindi in presenza di una nozione che potremmo dire di valenza ontologica. E’ una posizione che contrasta quella dell’antica Roma ove la dignitas non era collegata (ontologicamente) alla persona umana, ma era costituita da una carica pubblica, che veniva attribuita appunto ad alcuni “dignitari”. Non tutti gli uomini – e soprattutto le donne – erano degni di ricevere questo onore, che era appannaggio solamente di alcuni.
Per Gesù avveniva un movimento opposto: non solo egli aveva un’attenzione privilegiata per i poveri e per i deboli, ma giunge addirittura ad identificarsi con loro. Ricordo le pagine straordinarie e sconvolgenti delle “Beatitudini” ove i poveri, i deboli, gli afflitti vengono chiamati “beati”. Ovviamente non è beata la malattia, la povertà, l’afflizione. La beatitudine è rivolta alle persone, le quali non solo non perdono la dignità in quelle condizione ma sono privilegiate dall’attenzione di Dio stesso. Quindi, non solo non perdono la dignità, ma sono addirittura elevati ad essere rappresentanti di Dio sulla terra.
Ovviamente questo modo di concepire la dignità della persona dipende da due premesse, da non dare per scontate: la prima è la convinzione dell’esistenza di Dio e la seconda è la distinzione tra “chi” è veramente umano – e quindi fatto a immagine e somiglianza di Dio – e chi non lo è ancora o non lo è più. Entrambe queste premesse, in modi diversi, non sono più salde ovunque. La prima è inficiata da una cultura secolarizzata, la seconda si scontra con tradizioni culturali che non marcano chiaramente il confine dell’umano. Certo, è ormai superato il dibattito che sorse al momento della scoperta delle Americhe, quando ci si chiedeva addirittura se gli indigeni fossero pienamente umani. Ci fu una accesa disputa agli inizi del XVI secolo tra il filosofo Ginès de Sepulveda e il vescovo di Chiapas Bartolomé de Las Casas. Per venire all’oggi, vi è un dibattito che non possiamo considerare troppo frettolosamente superato, perché potrebbe ripresentarsi in relazione agli esseri (che qualcuno chiama già post-umani) resi possibili dalla chirurgia dei trapianti o dagli interventi in campo genetico (o epigenetico) o addirittura dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale. È qui che possiamo menzionare il secondo contributo determinante nella riflessione dell’Occidente, cioè quello di I. Kant.
La svolta kantiana
Nei Fondamenti della critica dei costumi, alla fine della seconda sezione, Kant formula una proposizione che avrà un seguito enorme nella civiltà occidentale. Egli afferma che la condizione per cui qualcosa è un fine in sé, cui è impossibile attribuire un prezzo, è la dignità, in quanto valore intrinseco alla persona. Tale dignità non è suscettibile di una stima economica e non è né graduabile, né divisibile, in modo tale che tutti gli uomini sono degni della stessa dignità e invitati a portare rispetto verso tutti gli altri. Kant fonda questa dignità sulla legge morale che ognuno trova dentro di sé. In un certo senso quindi “laicizza” quanto nella tradizione cristiana risultava dipendente dalla relazione con Dio. Per inciso possiamo notare che GS 16, parlando della coscienza dell’uomo come luogo in cui ciascuno scopre una legge che non si è dato da sé, ma che è scritta da Dio, opera una saldatura tra le due prospettive[1].
In ogni caso la domanda che si pone a questo punto è se la legge morale di cui parla Kant sia presente in tutti gli esseri umani. Che dire di quelli che compiono delitti efferati o hanno deficit neurologici, per cui sembrano privi anche solo di ogni consapevolezza? Certo occorrerebbe qui una risposta elaborata e approfondita perché l’obiezione è senz’altro rilevante. Ma ora ci basti dire che la crudeltà che alcuni assassini mostrano nei confronti delle loro vittime, può essere interpretata non tanto come assenza della dignità, ma al contrario proprio come segno della sua persistenza. Perché l’accanimento della violenza, nel suo modo di infierire sulla vittima che deve essere eliminata, dice di più della volontà di eliminare un ostacolo o un avversario. Parla il linguaggio dell’odio distruttivo, che gode di infliggere sofferenza, umiliazione, disprezzo. Alcuni fanno notare giustamente che si esprime in tal modo un tentativo – per quanto orribile – di cancellare la resistenza dell’umana sensibilità all’orrore della violenza fine a se stessa, per soffocare il rimorso di cui la coscienza chiederà conto. I colpi in eccesso sono rivolti verso di sé, più che verso la vittima. Il diritto protegge l’assassino da chi vuole fare giustizia sommaria, in nome dell’umanità che anche in lui deve essere infine riconosciuta, a dispetto di tutto, pur nella condanna e nella punizione del delitto. In questo modo, protegge l’umanità di cui egli stesso partecipa, l’umanità che egli condivide con noi. E come se cercasse di proteggere questa sua umanità, separandolo dal suo delitto: “in quanto essere umano, tu sei più di questo orrore commesso, e vali di più di ciò che in te ha preso il sopravvento”. Il rispetto fondamentale che la legge prescrive, anche per il reo di orribili delitti, contraddice e giudica la mancanza di rispetto che ha guidato il suo disprezzo per la dignità umana: nell’altro e in se stesso.
L’oscuramento della sensibilità può arrivare anche a paralizzare ogni rimorso degli atti crudeli compiuti, fino a estinguere ogni apparenza di coscienza morale. La totale mancanza di sensibilità morale appare allora come una vera e propria patologia: una malattia che è necessario curare più che punire. Siamo di fronte a una situazione che possiamo valutare soltanto in rapporto ai segni empirici – emozionali e comportamentali, psichici e organici. Forse la legge morale continua a vivere, nel profondo della coscienza, ma non trova riscontro nella soggettività manifesta: non c’è più la sensibilità, né la forza, di accogliere il rimprovero della coscienza morale. Qualcuno vede rappresentata questa situazione nel quadro dell’urlo di Munch: la coscienza grida, ma non si sente nulla, come se nella persona si siano spenti i recettori in grado di captare quella voce. La legge morale è sempre presente: sia che la si ascolti, sia che la si renda muta; sia che la si colga, ma senza la forza di seguirla; sia che vengano a mancare i mezzi per riconoscerla, anche quando cerca il modo di esprimersi.
Epoca moderna
Nell’epoca moderna si è progressivamente diventati più sensibili alla dimensione relazionale, riconoscendo il ruolo fondamentale giocato dall’altro nell’accedere alla propria dignità. Occorre, per prenderne coscienza, che gli altri la riconoscano in me. Nella fenomenologia dello spirito, Hegel afferma che: “Se la mia dignità non è riconosciuta dagli altri, essa non esiste pienamente”. Egli non dice che la riconoscenza degli altri fa esistere la dignità, ma che senza la riconoscenza non esiste pienamente. Quindi non basta dire che la dignità dell’uomo si trova nello sguardo che si porta su di lui. La dignità anzi precede la riconoscenza, ma quest’ultima compie e realizza la prima. Quando nelle cure palliative si dice che non si perde la propria dignità se si è guardati con dignità, si intende il sentimento della propria dignità, non la sua dimensione ontologica, che appunto non si può mai perdere. Se ne può perdere il sentimento, e lo sguardo di ciascuno di noi può dare un po’ di coraggio e di serenità a chi dubita della propria dignità, perché magari si trova incontinente per la malattia e calvo per la terapia. Si vede allora quanto sia importante favorire condizioni di cura, soprattutto in contesti fortemente invalidanti o di morte prossima che corrispondano alla dignità umana e ne favoriscano il più possibile il riconoscimento.
Ma nelle fasi più avanzate della modernità, la dignità della persona è stata interpretata in modo sempre più connesso con il suo grado di autonomia, di controllo, di indipendenza. Questa è la convinzione di coloro che sono favorevoli alla eutanasia. Anche grazie ai crescenti poteri acquisiti con la rivoluzione scientifica di controllare le forze naturali e di volgerle a vantaggio dell’uomo, la dignità è divenuta relativa alla capacità di essere autocoscienti e razionali, di esercitare il controllo e in ultima analisi di autodeterminarsi. Chi non è provvisto di queste capacità attuali sarebbe privo di dignità.
Questa impostazione è andata di pari passo con scelte non del tutto tematizzate nella loro portata, che hanno eroso praticamente, spesso in modo quasi inavvertito, il significato della dignità. Non sono immediatamente all’interno del campo bioetico, però certamente hanno una ricaduta sulla mentalità diffusa e anche sui presupposti impliciti delle argomentazioni in bioetica. Sono pratiche che assegnano valori diversi alla vita fino a considerare priva di ogni valore la vita di alcuni esseri umani. Per giungere a questo esito ha notevole rilievo l’enfasi oggi posta sulla vita in quanto conosciuta con le categorie delle scienze empiriche. La dimensione biologica tende così a divenire criterio di riferimento per l’interpretazione della vita, emarginando la prospettiva biografica. Facciamo l’esempio dei trattamenti imposti agli migranti. Negli anni ’90, quando diversi Paesi europei hanno progressivamente chiuso le porte per l’ingresso dei migranti per motivi economici, come anche per i rifugiati politici, alcuni Paesi (come la Francia) fecero delle eccezioni. Si aggiunse un nuovo criterio di regolazione, basato su parametri sanitari: uno straniero in situazione irregolare la cui vita fosse minacciata da una malattia non curabile nel suo Paese di origine, poteva ottenere il permesso di soggiorno e la copertura sanitaria per le cure mediche. Si è così assistito a un progressivo aumento delle persone presenti per ragioni sanitarie, al punto da superare negli anni 2000 il numero di persone che godevano dello statuto di rifugiato. Le cose sono poi diventate più complesse, ma è interessante notare lo slittamento che si è operato nella responsabilità verso la vita: si aiutano più facilmente le persone esposte alle patologie che quelle minacciate dalle persecuzioni. Il certificato medico è più credibile del racconto dei richiedenti asilo. Si sviluppa una preminenza del biologico sul biografico, pur su basi spesso discutibili, che conducono a una sorta di “cittadinanza biologica”, cioè al riconoscimento di un posto legittimo nella società in forza di criteri biologici. Si potrebbero citare altri esempi in cui il riscontro di alcune malattie in persone che vivono in contesti abitativi svantaggiati è stato il motivo per migliorare le politiche della casa: per indurre le autorità all’azione è stato necessario tradurre le diseguaglianze sociali nel linguaggio della malattia e della biologia.
Esempi analoghi possono essere fatti anche in campo economico. Un caso emblematico è quello delle assicurazioni sulla vita, che si sono imposte nel XIX secolo, e dell’indennità per gli incidenti sul lavoro. Così non solo le vite vengono sottoposte a una valutazione che conduce alla stima di un prezzo corrispettivo, ma anche tale somma è diversa da caso a caso. Due elementi, la gradualità e la disparità, che abbiamo visto essere del tutto incompatibili con la nozione di dignità. Situazioni simili si è creata con il fondo di compensazione istituito dopo l’attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001. Le famiglie sono state indennizzate in funzione degli stipendi dei loro parenti deceduti. Così alcune famiglie hanno ricevuto delle somme fino a otto volte superiori rispetto ad altre. Questa modalità meccanica ha fatto anche sì che le donne ricevessero sistematicamente una valutazione più bassa rispetto ai maschi, in media di un terzo inferiore. Entrano quindi anche elementi attinenti alla disparità di genere.
I tre poli della nozione di dignità
L’esercizio di ascolto che abbiamo svolto ripercorrendo in sintesi alcuni snodi particolarmente importanti nella riflessione sulla dignità, ci mostra come da una parte diversi contributi forniscano indicazioni preziose e dall’altra sia importante accogliere con discernimento tali indicazioni, articolandole in modo per quanto possibile organico. La complessità dell’essere umano richiede di lavorare in questa linea, di cui il cammino che stiamo facendo qui insieme può essere un esempio. Occorre anzitutto tenere insieme la duplice valenza della dignità, che è allo stesso tempo sia dono sia compito, sia fondamento sia obiettivo da perseguire. Potremmo poi assumere le considerazioni fatte sopra, aggregandole in tre poli: quello della dignità in quanto ontologicamente costitutiva dell’essere umano, quello soggettivo, in cui la dignità risuona sul piano dell’esperienza vissuta, e quello oggettivo, in cui la dignità si dispiega operativamente nel mondo esterno attraverso l’agire. Essi vanno tenuti presenti nel loro insieme, senza eliderne nessuno e riconoscendone al contempo la diversità e la reciproca interazione.
Il primo nucleo riguarda la dignità ontologica intrinseca, legata all’appartenenza di ciascuno alla specie umana, al cui interno viene all’esistenza. È un livello decisivo, concettualmente previo ad ogni altro dato, che non può essere negato se non riducendo a nulla sia l’umanità dell’altro sia la propria. Pur essendo il livello fondamentale, occorre riconoscerne una certa formalità, che il polo successivo aiuta a rendere più vicino e più accessibile.
Su questo secondo piano troviamo il riverbero interiore e vissuto della dignità. Lo potremmo anche chiamare fenomenologico, nel senso che riguarda il sentimento esperito della propria dignità, strettamente collegato all’immagine e alla stima di sé. È qui che assume rilievo non solo teorico, ma effettivamente sperimentato la relazione con gli altri, come luogo in cui progredisce da una parte la consapevolezza della propria dignità attraverso l’altrui riconoscimento e dall’altra la comprensione della dinamica di reciprocità che la caratterizza. Infatti in positivo è possibile esigere il rispetto della propria dignità solo in quanto ciascuno la esige senza parzialità anche per ogni altro essere umano. E in negativo, contraddire la dignità dell’altro è con uno stesso gesto contraddire la propria.
Anche l’apprezzamento con cui ciascuno percepisce i propri atti ha un riverbero sul piano della dignità “vissuta”. Essi suscitano infatti gioia, soddisfazione, rimorso, delusione… Ma fermarsi su questo piano significa essere sommersi dall’emotività. Del resto anche la vergogna dovuta al fallimento, all’insuccesso, alla mancata corrispondenza alle altrui attese e alle norme sociali non è facile da gestire in situazioni di particolare difficoltà, come quelle che in caso di grave e invalidante malattia possono condurre alla richiesta di eutanasia. Il richiamo alla dimensione ontologica, insieme a relazioni che facciano sperimentare un’accoglienza che va oltre quanto è immediatamente apparente, costituisce un valido polo di resistenza rispetto all’immediatezza del sentimento, arginando una tendenza che oggi è sempre più diffusa.
Infine l’essere soggetti dotati di una dignità inerente alla propria natura, invita ad agire e a esistere in modo conforme al dono ricevuto, a intraprendere la via dell’umanizzazione, cioè a determinarsi concretamente nel senso di ciò che si è. La dignità obiettiva proietta così la persona nel mondo per mettere in opera questa umanità. La distanza dall’ideale e l’impatto del limite non sono necessariamente colpevoli quando sono determinati da un male e da una finitezza non volontariamente scelte. Qualora i comportamenti non fossero in grado di esprimere responsabilmente la dignità costitutiva della persona, quest’ultima rimane comunque per segnalare che ogni persona è sempre molto di più della somma dei suoi atti, anche quando indegni della sua umanità. Inoltre questo dispiegarsi in atto della dignità sottolinea come i comportamenti non vadano mai isolati dal soggetto agente.
Circolare tra questi tre poli significa riconoscere e assumere la complessità dell’essere umano che sempre più riconosciamo affermarsi nella cultura contemporanea. La dignità non fornisce soluzioni immediate alle questioni della bioetica, ma invita a prendere sul serio le diverse dimensioni che le sono proprie per affrontare le domande che ci vengono poste. A convocare le diverse dimensioni del sapere senza idolatrare nessuno di questi poli sotto pena di cadere rispettivamente nel formalismo astratto o nell’emotività soggettivista o nell’esteriorità legalista.
Conclusione
Il cristianesimo porta i suoi argomenti a questa impostazione che vuole prendere in conto e articolare diverse dimensioni. Il cristiano non rispetta l’altro e se stesso in funzione dei beni o della salute, di quanto può apportare a sé o alla società, ma in quanto figlio nel Figlio, primo nato dai morti, immagine del Dio invisibile. La dignità filiale è fondamento dell’uguaglianza di tutti gli umani, che conduce a rifiutare ogni discriminazione. Allo stesso tempo la dignità dispiegata nell’agire non è sempre all’altezza del dono di Dio e la confessione delle proprie inadempienze esprime la cognizione di non aver sempre risposto della dignità filiale gratuitamente ricevuta con atti corrispondenti a questa appartenenza. E questa esperienza di perdono è senz’altro luogo privilegiato in cui può rinnovarsi la consapevolezza di una dignità che nessuna condizione o condotta può sopprimere.
[1] L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessa dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato (17). La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità (18). GS 16.